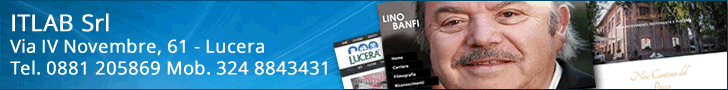I proverbi e i modi di dire lucerini sono tanti. Di solito la loro origine è lontana e frutto di culture passate. Molto spesso hanno alle loro spalle un riferimento ben preciso, ovvero una storia e un significato, che non molti conoscono, dato che si tratta di detti appartenenti alla tradizione, alcuni scomparsi e altri poco in uso. Allora, non è mai troppo tardi per riproporli e questa rubrica offre un’opportunità piacevole, e speriamo interessante, per saperne di più.
“TÉNE ‘A BBURZÈTTE CH’I FEGURÈLLE NGANNE”
Traduzione: (Porta al collo il sacchetto di stoffa che custodisce sacre immagini)
Significato: “Era il sacchetto di stoffa a forma di cuore con inserite le “ mmagenètte”, l’immagini di Gesù, della Madonna o dei Santi.”
Curiosità: “Fino agli anni 60’ del secolo scorso sono rimaste in vita a Lucera usanze e tradizioni, ricche di simbologia e di religiosità che si riallacciavano a miti pagani di un mondo ancestrale, in cui sacro e profano continuamente si confondevano. Un esempio tipico è rappresentato dalla “BBURZÈTTE CH’I FEGURÈLLE”, che si portava al collo o si cucivano sui vestiti dei neonati, tradizione che derivava da una borchia che i giovanetti patrizi o liberi romani portavano appeso al collo fino al 17° anno quando lo deponevano insieme alla toga praetexta ed indossavano quella virile e contenente amuleti vari. Il Cristianesimo ha ereditato questa usanza e la ha arricchita di altri significati, sostituendo gli amuleti con reliquie dei santi o presunte tali e, in epoche più recenti, da figure di santini di cui si era particolarmente devoti, con continue invocazioni e baci per ottenere miracoli o particolari favori. Un altro aspetto delle tradizioni popolari lucerine in bilico tra il sacro e profano era quella della credenza di sentirsi protetto dalle difficoltà vestendo di sacro, anche questa tradizione ereditata dall’antica Grecia e Roma in cui era usanza di vestire i bambini con i simboli di alcune divinità non solo per avere delle grazie ma anche per placare l’ira delle divinità. In epoca cristiana era stata intodotta l’usanza di vestire i bambini con un abitino monacale,
“ U VESTÍTE DE MUNACÌLLE “ consistente in un saio marrone, un cordone bianco in vita e i sandali, alcune volte anche i capelli tagliati alla monacale, per ringraziare Sant’Antonio da Padova per grazie ricevute o per porre il bimbo sotto la protezione del Santo perché si facesse interprete della richiesta di una grazia.. Il periodo di vestizione era legato all’importanza che si dava all’aspettativa di una guarigione, di una grazia, di un miracolo. In genere la durata del voto era di tredici mesi oppure u vestíte de munacìlle una volta indossato, non si poteva togliere più fino a quando non diventavano logori. Il bambino con il suo vestito da monachello veniva spesso immortalato da una fotografia che veniva attaccata alla campana di vetro che era presente in ogni casa, come rafforzamento del ringrazianamento o della richiesta di grazia. Non avendo altre speranze la povera gente si rivolgeva all’aiuto dei santi sacralizzando tutto, portando nel portafoglio medaglie o immaginette, tenendo nella propria casa statue, crocifissi quadri, o arrichendo le strade con immagini, croci, edicole. In ogni casa di Lucera, nella camera da letto, c’era poi il quadro di Sant’Antonio o del Sacro Cuore che era il regalo di nozze che i genitori facevano ai propri figli quando si sposavano.
Rubrica di Lino Montanaro & Lino Zicca