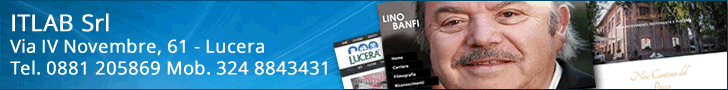Ci sono espressioni dialettali, come questa, che, a differenza dell’italiano, riescono ad esprimere compiutamente certi concetti.
Fino a non tanti decenni fa, per le famiglie lucerine era una necessità maritare le figlie femmine, perché le donne, all’epoca, perlopiù non lavoravano e, quindi, si doveva pensare all’avvenire di queste ragazze.
Succedeva, a volte, che questo intendimento era ostacolato dalla mancanza di una adeguata dote oppure dal fatto che la ragazza non fosse particolarmente bella oppure dalla difficoltà di “trovare” un buon partito.
Diventava, pertanto, necessario ricorrere a qualche sotterfugio per ottenere un buon matrimonio. Si individuava allora un ragazzo abbunate (ragazzo bravo e buono), che se facève jjénghe de cape – se facève abbùurà (veniva circuito) con le attenzioni e il saper fare dalla famiglia della ragazza, che era indotto al fidanzamento e al matrimonio, spesso contro il volere della propria famiglia.
Una sorta di circonvenzione di ingenuo, facendolo allontanare pian piano dalla sua famiglia d’origine. Nel nostro dialetto questa situazione veniva indicata con la locuzione in premessa: se l’ànne trasúte dinde. La frase veniva pronunciata generalmente dalla madre del ragazzo quando non era d’accordo, la quale diceva anche : povere fèsse s’è fatte mètte a vunnèlla ‘ngape.
Qualche volta le continue sollecitazioni della famiglia d’origine riuscivano a convincere il ragazzo della trappola in cui era caduto, ma, spesso, veniva celebrato il matrimonio in assenza della famiglia sposo, con rancori che duravano anche tutta la vita.
La stessa frase veniva pronunciata dagli amici di un ragazzo, quando si fidanzava ufficialmente e abbandonava progressivamente la compagnia degli amici di sempre o, ancora, quando una persona anziana veniva circuita da gente di pochi scrupoli, con lo scopo di impossessarsi delle sue sostanze e dei suoi beni immobili.