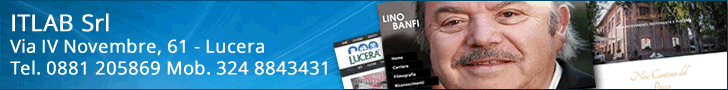I lunghi preparativi per un matrimonio non sono una novità di oggi, perché anche nella Lucera di una volta i preparativi incominciavano molti mesi prima, soprattutto per impedire che sorgessero dubbi (‘a ggènde ce mettèsse ‘a jonde ) che un matrimonio a breve scadenza nascondesse il fatto che i fidanzati avessero fatto la fuitina (se n’avevène avúta fuje) oppure che la ragazza era incinta (prène) .
Non esistendo ancora l’invito scritto di nozze, i fidanzati, accompagnati dalla mamma di lei, facevano u ggíre di sètte chíjse, cioè si recavano nelle case di parenti, amici e personaggi di un certo riguardo, questi ultimi scelti spesso per fare il testimone di nozze (u cumbare e ‘a cummare), per invitarli al matrimonio.
Qualche giorno prima della data stabilita, dopo che era stata preparata la nuova casa degli sposi, partiva dal laboratorio della sarta, un cesto (‘a spasa) che conteneva il vestito da sposa e i velo (u vestíte d’a spose e u vèle), portato da ragazze nubili in corteo che aveva lo scopo di mettere in bella mostra l’abito nuziale.
Nella casa della sposa venivano esposti il corredo e i regali (u currède e i rijale), sotto l’attenta vigilanza della madre dello sposo (‘a sogre).
La settimana precedente alle nozze, i fidanzati non si dovevano vedere (‘a sèttemane d’u rèspette).
Il giorno del matrimonio per recarsi in chiesa si andava in corteo a piedi (a ppíde) oppure, per i matrimoni della borghesia lucerina, con le carrozze (ch’i carrozze), con un corteo aperto dalla carrozza degli sposi (d’i spúse) e chiuso dalle nubili (‘a carrozze d’i figghjóle zíte) . Terminata la funzione religiosa, ci si recava a casa o presso una sala affittata per un semplice rinfresco ove veniva servito il gelato (u spumóne) , biscottini friabili tipo wafer (i fru-fru) , gli amaretti (i marètte) , grossi bignè con la crema (i ssciù) , il rosorio (u resoreje) e la torta (‘a torte), tagliata dagli sposi.
Famose erano la sala messa a disposizione da Don Peppino Rossetti (U Negus), parroco della Chiesa della Chiesa del Carmine, situata nel quartiere La Torretta (sóp’a Turrètte) e l’Enal, sala situata in fondo a Corso Garibaldi, dove erano, disposte sedie lungo il salone, con al centro il tavolo degli sposi.
Alla fine del rinfresco prima passavano gli sposi a distribuire i confetti (i cunfítte) agli invitati, poi, quest’ultimi, in fila, ritiravano dagli sposi ‘a bburzètte, un piccolo vassoio (‘a guandíre), contenente dolcetti vari.
Nel corso degli anni sessanta arrivò il complesso musicale che rallegrava il rinfresco. Successivamente, si passò dal rinfresco ai pranzi presso ristoranti e le sale per ricevimenti chiusero i battenti.
Dopo le immancabili lacrime della sposa nel salutare i parenti, i poveri sposi stanchissimi, (stanghe e strutte) , si ritiravano nella casa nuziale, accompagnati dagli sfottò degli amici dello sposo (uagliúnastre), che davanti casa intonavano gli sfottò di rito (sfruculjamìnde) , tipo: “Quanne víde u litte tíse tíse, a ttè u chiande e a mmè u ríse” (Quando vedi il letto pronto, tu piangi e io sto già pregustando).