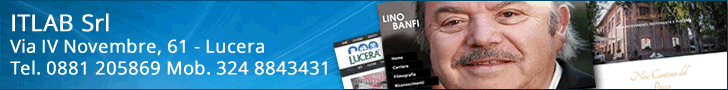“Dialettando” , la rubrica di Lino Montanaro propone tutti i giovedì proverbi e modi di dire lucerini, tramandati di generazione in generazione, per non dimenticare le origini della nostra amata Lucera.
“Dialettando” , la rubrica di Lino Montanaro propone tutti i giovedì proverbi e modi di dire lucerini, tramandati di generazione in generazione, per non dimenticare le origini della nostra amata Lucera.
I dialetti, come tutte le cose, cambiano nel tempo, inesorabilmente, anzi sono soggetti a un processo di italianizzazione, con il risultato di perdere i propri tratti caratteristici, sostituiti con i corrispondenti dell’italiano. Pertanto, vi sono alcune particolari parole del dialetto lucerino che sono ormai desuete, non le utilizza più nessuno.
Eccone alcuni esempi:
• CHE, TÉNE U MIRCHE NGÚLE? = Non ti arrabbiare, ma per me è difficile riconoscere qualcosa fra due o più oggetti più o meno uguali, dove per MIRCHE si intende MARCHIO
• QUANNE MORE ME VACHE A JETTÀ ABBASSCE I PIGNATÌLLE = Sono sconcertato dal verificarsi di tante circostanze sfavorevoli, dove per PIGNATÌLLE si intende CIMITERO
• ASSEMÈGGHJE ‘A PUTÉCHE CASÈDDÚGLJE = È una casa dove c’è disordine e accumulo di oggetti, al punto che è bene farsi qualche domanda, dove per PUTÉCHE CASÈDDÚGLJE si intende RIVENDITA OLIO
• QUILL’ÈJA VÚNE CHE ME DACE SÈMBE ‘A PUSÈTECHE = È una persona che non la finisce mai di infastidirmi, dove per PUSÈTECHE si intende PERSECUZIONE
• À LASSATE U MÚNNE NDUMAREJE = Ha improvvisamente interrotto quello che stava facendo, dove per NDUMAREJE si intende IN SOSPESO
• È VVENÚTE DE CARRÉRE E À NDANATE = È arrivato velocemente ed ha sistemato tutto, dove per NDANATE si intende SISTEMARE
• U VESTÍTE NÚVE SE L’È MMÌSSE NDUSSCE-NDUSSCE = Ha rovinato l’abito della festa , dove per NDUSSCE-NDUSSCE si intende SENZA RIGUARDO
• NZE PO’ FFÀ NINDE PECCHÈ È SSCIÚTE NU NDÚPPE = Non ne facciamo niente perché è sorto un problema, dove per NDÚPPE si intende INTOPPO
• QUILL’ÈJA VÚNE CHE FACE SÈMBE U CUNDEGNÚSE = È una persona che si comporta sempre con gravità e riservatezza, dove per CUNDEGNÚSE si intende PERSONA RITROSA
•STÉNGHE ACCUSSÌ STRACQUE E STRÚTTE CHE NNE MM’AFÍDE MANGHE A GALIJÀ = Sono così stremato, spossato, che non riesco neanche a parlare, dove per GALIJÀ si intende RESPIRARE
• QUILLE È VÚNE CHE ‘A NOTTE VACE SCKITTE SBERIJANNE = È una persona che di notte girovagando, dove per SBERIJANNE si intende ESSERE SEMPRE IN GIRO
• TUTTE ‘NA VÓTE S’È MMUSSATE = Improvvisamente si è corrucciato, dove per MMUSSATE si intende METTERE IL MUSO
• A CHI È VVÍSTE A NÚDE, CHE T’È VVENÚTE U GGHJARÚLE? = Spiegazione folcloristica per l’insorgere di una infezione ad un occhio, dove per GGHJARÚLE si intende ORZAIOLO
• A NDÒ VAJE, ‘A MBORCHJE? = Modo di dire per indicare che l’interlocutore sta andando in luogo lontano, dove per MBORCHJE si intende LUOGO IMMAGINARIO
.
REGOLE DI PRONUNCIA
Il dialetto lucerino, come del resto ogni dialetto, ha le sue ben precise e non sempre semplici regole di pronuncia. Tutto questo, però, genera inevitabilmente l’esigenza di rispettare queste regole non solo nel parlare, ma anche e soprattutto nello scrivere in dialetto lucerino. Considerato che il fine di questa rubrica è proprio quello di tener vivo e diffondere il nostro dialetto, offrendo così a tutti, lucerini e non, la possibilità di avvicinarvisi e comprenderlo quanto più possibile, si ritiene di fare cosa giusta nel riepilogare brevemente alcune regole semplici ma essenziali di pronuncia, e quindi di scrittura dialettale, suggerite dall’amico Massimiliano Monaco.
1) La vocale “e” senza accento è sempre muta e pertanto non si pronuncia (spandecà), tranne quando funge da congiunzione o particella pronominale (e, che); negli altri casi, ossia quando la si deve pronunciare, essa è infatti sempre accentata (sciulutèzze, ‘a strètte de Ciacianèlle).
2) L’accento grave sulle vocali “à, è, ì, ò, ù” va letto con un suono aperto (àreve, èreve, jìneme, sòrete, basciù), mentre l’accento acuto “á, é, í, ó, ú” è utilizzato per contraddistinguere le moltissime vocali che nella nostra lingua dialettale hanno un suono molto chiuso (‘a cucchiáre, ‘a néve, u rebbullíte, u vóve, síme júte), e che tuttavia non vanno confuse con una e muta (u delóre, u veléne, ‘u sapéve, Lucére).
3) Il trigramma “sck” richiede la pronuncia alla napoletana (‘a sckafaróje, ‘a sckanáte).
4) Per quanto riguarda le consonanti di natura affine “c-g, d-t, p-b, s-z” è stata adottata la grafia più vicina alla pronuncia popolare (Andonije, Cungètte, zumbà) quella, per intenderci, punibile con la matita blu nei compiti in classe.
5) Per rafforzare il suono iniziale di alcuni termini, si rende necessario raddoppiare la consonante iniziale (pe bbèlle vedè, a bbune-a bbune, nn’è cósa túje) o, nel caso di vocale iniziale, accentarla (àcede, ùcchije).
6) Infine, la caduta di una consonante o di una vocale viene sempre indicata da un apostrofo (Antonietta: ‘Ndunètte; l’orologio a pendolo: ‘a ‘llorge; nel vicolo: ‘nda strètte).
[LINO MONTANARO BIOGRAFIA E PUBBLICAZIONI PRECEDENTI]