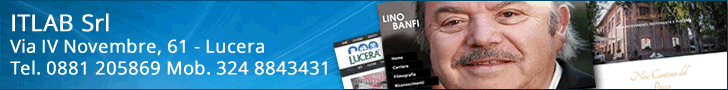Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.
Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.
I CUNDE
‘U GALLE E U SÓRECE’
 Nu jurne u galle jéve p’i fatte suje e truuaje pe nnanze u sórece e ppecché tenévene fame se mettijene ngamine, cercanne de puté maggnà.
Nu jurne u galle jéve p’i fatte suje e truuaje pe nnanze u sórece e ppecché tenévene fame se mettijene ngamine, cercanne de puté maggnà.
Se pegghjajene nu sacche e ttrasijene dind’a nu vosche de nuce ca nen fenéve maje.
U galle zumbaje sóp’a n’áreve, u sórece rumaneje nderre pe rrecogghje e mmette dinde u sacche i nuce ca u cumbagne l’eva menà da sope.
U sórece ca vuléve pegghja pe fèsse u galle se maggnave tutt’i nuce e i scorze i mettéve dinde u sacche.
Doppe nu bbèlle poche, u galle addumannaje: “S’è chjìne stu cazze de sacche?”
“None, ce vole timbe, u sacche èje angore mizze”, respunneje u sórece; e u galle cugghjeve, cugghjeve sèmbe.
Ngape a n’atu bbélle poche, turnaje a ddummannà: “Ne, cumbà, è cchjene mò”
“Nenn’angore; pinze a cogghje, tu, ca po’ t’avvise ije stesse”.
U galle cugghjeve, cugghjeve sèmbe, tramènde ca i nuce, manghe a ddirle, nne jévene a ffenì dinde u sacche ma dinde a trippe u sórece.
A ll’uteme di cunte, u galle nze putije cchjù mandené e vvulije vedé propreje che l’ucchje suje andó ère arrevate u sacche; e quanne s’addunaje ca i fatighe érene a u vinde, dije, tutte ngazzate, nu pizzele fforte ngape a u sórece ca i facije nu fusse tant’affunne ca se vedévene i cerevèlle.
U póvere sórece spavendate, se ne scappaje chiaggnenne.
Vija facénne, truuaje nu cane e ce décije: “Cane, ca’, damme n’u pile! U pile m’u mette ngape, pecché cumba galle m’a rotte a cape, pe mmezza noce ca m’agghje maggnate”.
U cane, pe ttutta resposte, i cercaje nu tuzze de pane.
U sórece ije da nu furnare e cce déceje: “Furnare, furnà, damme u pane ca ce l’agghja dà o’ cane, ca m’adda dà u pile; u pile me l’agghja mette ngape pecché cumba galle m’a rotte ‘a cape pe mezza noce ca magghje maggnate”.
U furnare respunneje: “Te denghe u pane, te ne denghe quande ne vù. Ma tu m’ai dà na sàleme de leggne”.
U povere sórece cchjù murte ca vive, se strasscinaje fin’o’ vosche e ddecije: “Vosche, vó, damme nu fasce de legne, ca ce l’agghja dà o’ furnare; u furnare me dace u pane; u pane ci’u denghe o’ cane, u cane me dace u pile, u pile me l’agghia mette ngape, pecché cumba galle m’a rotte a cape pe mezza noce che magghje maggnate”.
U vosche, pe nen u sende chiaggne, i respunneje: “Te denghe tutt’i leggne ca vu’, se prime me daje l’acque”
U sórece nze fedave propreje cchjù, ma pure se strasscenaje sine a jummare e susperaje: “Jummara, jummà, damme l’acqque ca ce l’agghja dà o’ vosche, u vosche, me dace nu fasce de legne, ca ce l’agghja dà o’ furnare; u furnare me dace u pane; u pane ci’u denghe o’ cane, u cane me dace u pile, u pile me l’agghia mette ngape, pecché cumba galle m’a rotte a cape pe mezza noce che magghje maggnate”.
A jummare, fenalmende, i facije a grazzeje. Ma u cazze du sórece, p’a prjezze de puterse aggiustà a cape, se vevije tande e ttande de quell’acque, ca s’abbuttaje cume nu ruspe, e, unu uà sckattaje.
Quanne u galle arrevaje pure isse a jummare, vedije u sórece che ère sckattate e ttutte cundende se mettije a candà: “Chicchirichì, Chicchirichì”.
IL GALLO E IL TOPO
Un giorno il gallo andava per i fatti suoi e trovò davanti il topo e siccome avevano fame si misero in cammino per cercare di poter mangiare.
Si presero un sacco ed entrarono in un bosco di noci che non finiva mai.
Il gallo saltò sopra un albero, il topo rimase per terra per raccogliere e mettere nel sacco le noci che l’amico gli doveva lanciare da sopra.
Il topo che voleva far fesso il gallo si mangiava tutte le noci e le bucce le metteva nel sacco.
Dopo un bel poco di tempo, il gallo domandò: “Si è riempito questo cazzo di sacco?”.
“Nooo, ci vuole tempo, il sacco è ancora a metà”, rispose il topo; e il gallo raccoglieva, raccoglieva sempre.
Dopo parecchio tempo, tornò a domandare: “Neh, compare, è pieno adesso?”.
“Non ancora, pensa a raccogliere, tu, che dopo ti avviso io stesso”.
Il gallo coglieva, coglieva sempre, mentre le noci, neanche a dirlo, non andavano a finire nel sacco ma nella pancia del topo.
Infine, il gallo non riuscì più a frenarsi e volle vedere con i suoi occhi dove erano arrivate le noci nel sacco e quando si accorse che il suo lavoro era finito al vento, diede, tutto arrabbiato, un pizzicotto forte sulla testa del topo che gli fece un buco così profondo che si vedeva il cervello.
Il povero topo spaventato, se ne scappò piangendo.
Strada facendo, trovò un cane e gli disse: “Cane, ca, dammi un pelo! Il pelo lo metto in testa, perché compare gallo mi ha rotto la testa, per mezza noce che mi sono mangiato”
Il cane, per tutta risposta, gli cercò un tozzo di pane.
Il topo andò da un fornaio e gli disse: “Fornaio, fornà, dammi il pane che lo devo dare al cane, che mi deve dare il pelo, il pelo lo devo mettere in testa perché compare gallo mi ha rotto la testa per mezza noce che mi sono mangjato”.
Il fornaio rispose: “Ti do il pane, te ne do quanto ne vuoi. Ma tu mi devi dare un mucchio di legna”.
Il povero topo più morto che vivo, si trascinò fino al bosco e disse: “Bosco, bo, dammi un fascio di legna, che la devo dare al fornaio, il fornaio mi da il pane, il pane lo do al cane, il cane mi da il pelo, il pelo me lo devo mettere in testa, perché compare gallo mi ha rotto la testa per mezza noce che mi sono mangiato”.
Il bosco, per non sentirlo piangere, gli rispose: “Ti do tutta la legna che vuoi, se prima mi dai l’acqua”.
Il topo non ce la faceva proprio più, ma pure si trascinò fino al torrente e sospirò: “Torrente, torre, dammi l’acqua che la devo dare al bosco, il bosco mi da un fascio di legna, che la devo dare al fornaio, il fornaio mi da il pane, il pane lo do al cane, il cane mi da il pelo, il pelo me lo devo mettere in testa, perché compare gallo mi ha rotto la testa per mezza noce che mi sono mangiato”.
Il torrente, finalmente, gli fece la grazia. Ma quel cazzo di topo, per la gioia di potersi aggiustare la testa, si bevve tanta acqua che si gonfiò come un rospo e, all’improvviso, scoppiò.
Quando il gallo arrivò anche lui al torrente, vide il topo che era scoppiato e tutto contento si mise a cantare: “Chicchirichì, Chicchirichì”.
Dal libro “IL DIALETTO DI LUCERA (FOGGIA)” di Francesco Piccolo