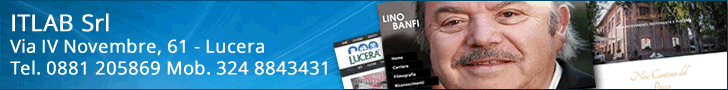Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.
Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.
I CUNDE
‘ ‘NA VÓTE SE MBENNÌJE CÓLE! ‘

Ce stéve ‘na vóte nu giòvene ca se chiamave Cóle. Quiste ére nu scapecerrate, ‘a mamme e u patre nge putèvene; nze pruccupave de ninde, penzave sulamènde a mmagnà e vvéve, a jjucà, a ffà fèste e a ddevagàrese ch’amice e ccumbagne.
Nzòmme ére pròbbete nu sscialacquóne.
Quille, u patre, ce l’éve ditte tanda vóte: “Figghje mije, n’i stènn’a ssènde, nda’ vedènzeje a sti cumbagne ca tine… Quisti qua mò’ te vàndene e tte pòrtene nghiande de mane; ma, pòver’a ttè quillu jurne, Ddije ce lìbbere!, si tu cade mbasscia fertune…. Nessciune, statte secure, te vén’a aiutà”.
Po’, prime de murì, ce facìje n’atu bbèlle trascurze.
“Sinde, figghje mije, aramàje ghije sònghe devendate vècchje assàje e, u saje, nze póte sapè, quille allassacrése póte capetà chè u Segnóre me chiame.
Tu u saje bbune, i cunziglje ca t’agghje date ne ll’àje velute maje sènde; mò’, te raccumanne, alméne mò’ stamm’a ssende e ccirche de fà quille ca te diche ghije.
U vi’ quillu chiùve grusse-grusse chè stace a llà, nzaccate dind’a quillu trave? Quanne ghije nge stènghe cchjù, pecché so mmurte, si rumane ndèrra chjane, pecché t’àje fenute tutte cóse, nde spaciendanne… Acciaffe na zóche bbèlla fattizze, nzapunìjele bbèlla bbèlle e vvatt’a mbènne pròbbete vecin’a qquillu chiùve, ca t’agghje fatte vedè mò’ ”.
Accussì nu bbèlle jurne, pròpreje cume l’éve ditte u patre, Cóle se truuàje sènza manghe cchjù n’amiche o nu cumbagne. Quiste, cume se n’addunàrene ca nge stève cchjù ninde da ssciuppechjà, sùbbete se ne jìrene tutte quande a vun’a vune.
Desperate, aramàje nz’a fedave cchjù de cambà sènza devertemènde, juche, fèmmene, viagge e allegrìje; allóre angegnàj’a ppenzà e ss’arrecurdàje d’i paróle du patre e: “Papà, – decìje – damme ‘a forze, damme u curagge de fà quille ch’agghja fà, damm’a bbenedezzióne, pecché alméne sta vóte te vogghje stà a ssènde”. Po’’ currìj’a ppegghjà ‘a zoche e ss’abbjaje.
Jije nd’u cammaróne, ndò stéve da tanda timbe quillu trave che qquillu chiùve grusse, ca l’éve nzengate u patre; nzapunàje ‘a zóche, a ttaccàje mbacci’o chiùve e cce facìje mbónde nu bbèlle nùdeche; po’ se facìje ‘a cróce, mettìje ‘a cape dind’u chiappe, u strengìje nganne e… quanne pigghj’e sse menàje abbasce da sóp’a sègge, ndò ére nghianate prime.
Mò’, chè éje, chè ne nn’éje? Se ne venìje u chiùve e u trave se rumbìje, própreje nd’a qquillu mumènde ca isse stéve murènne strafucate.
E, tramènde cadéve, che succedìje? Se strasscenàje appirze ‘na vòrza chjéne de marènghe d’óre, ca stéve ammucciate chisà da quanda timbe nd’a nu pertuse, arrét’o trave.
Quilli marènghe, pe cchi ne ll’avèsse angóre capite, l’éve misse u pòvere patre, ca penzàje: “Quanne fìgghjeme p’a desperazzióne se mbènne, p’u pìseme, se ne véne u chiuve, se rómbe u trave, e isse addevènde n’ata vóte ricche e mmètte giudizzeje”. E ccussì succedìje.
Quanne pò’ amice e ccumbagne sapìjene u fatte, pròbbete lóre ca se n’èrene fejute quanne isse avéve bbesugne, currìjene sùbbete e ffacèvene prejèzze.
Ma Cóle, chè ne nn’ére cchjù quille de prime, aramàje ére addevendate nu bbune figghje e ne nn’ére pe nninde fèsse, se mbrestecalìje bbrutte, i cacciàje fóre e lucculàje tutte ngacchjate:
“ ‘Na vóte se mbennìje Cóle!…“
UNA VOLTA S’IMPICCÒ NICOLA!
C’era una volta un giovane che si chiamava Nicola.
Questo era uno scapestrato, la mamma e il padre non avevano alcun potere su di lui; non si preoccupava di nulla, pensava solamente a mangiare e bere, a giocare, a festeggiare e a divertirsi con amici e compagni. Insomma era proprio dissoluto.
Il padre gliel’aveva detto tante volte. “Figlio mio, non dare ascolto,non dar retta ai compagni che hai… Questi ora ti vantano e ti portano in pianta di mano; ma, povero te, se dovesse capitarti un giorno, Dio liberi!, di cadere in miseria… Nessuno, puoi esserne certo, ti verrebbe in aiuto”.
E poi, prima di morire, il padre gli fece un altro bel discorso. “Senti, figlio mio, io ormai sono diventato molto vecchio e, tu lo sai, non si può sapere, può succedere che, all’improvviso, il Signore mi chiami a sé. Tu lo sai meglio di me, i consigli che ti ho dato nonli hai mai voluti ascoltare; ora, ti raccomando, almeno adesso obbediscimi e cerca di fare quello che ti dicoio. Vedi quel grosso chiodo che sta lì, piantato in quella trave? Quando io non ci sarò più, perché sarò morto, se rimarrai completamente al verde, perché hai dilapidato ogni cosa, non ti spazientire… Prendi una corda robusta, insaponala ben bene e va’ ad impiccarti proprio a quel chiodo, che ti ho fatto appena vedere”.
Così un bel giorno, proprio come aveva detto il padre, Nicola si trovò senza soldi e senza nemmeno un compagno o un amico. Questi, appena si erano accorti che da lui non c’era più nulla da ricavare, uno alla volta si erano allontanati tutti.
Disperato, ormai non ce la faceva più a vivere senza divertimenti, giochi, donne, viaggi ed allegria; incominciò allora a pensare e si ricordò delle parole del padre, e disse: “Papà, aiutami tu, dammi la forza, dammi il coraggio di fare quello che devo fare; dammi la tua benedizione, perché almeno questa volta ti voglio ubbidire”. Poi corse a prendere la corda e si mosse.
Andò nello stanzone, dove stava da molto tempo quella trave con quel grosso chiodo, che gli aveva indicato il padre; insaponò la corda, l’attaccò al chiodo e fece all’estremità di essa un nodo a regola d’arte; poi si fece il segno della croce, infilò la testa nel capestro, lo strinse intorno al collo… ed ecco si buttò giù dalla sedia, dove prima era salito.
Ora, che cos’è, che cosa non è? Si staccò il chiodo e la trave si spezzò, proprio nel momento in cui lui stava per morire strozzato.
E, mentre cadeva, che accadde? Si trascinò dietro una borsa piena di marenghi d’oro, che stava nascosta chissà da quanto tempo in un foro dietro la trave.
Quei marenghi, per chi non l’avesse ancora capito, lì aveva messi il povero padre, che aveva pensato: “Quando mio figlio per la disperazione s’impiccherà, il chiodo si staccherà a causa del peso, la trave si spezzerà, e lui diventerà di nuovo ricco e metterà giudizio”. E così avvenne.
Quando poi gli amici e i compagni vennero a conoscenza del fatto, proprio loro che quando lui aveva avuto bisogno lo avevano abbandonato, subito accorsero per festeggiarlo.
Ma Nicola, che non era più quello di una volta, ormai era diventato un bravo giovane e non era affatto stupido, si arrabbiò di brutto e lì cacciò via gridando esasperato:
“Una volta s’impiccò Nicola!…”.
Tratto dal libro “RACCONTI FAVOLE E LEGGENDE POPOLARI DI LUCERA” di Lella Chiarella e Domenico D’Agruma